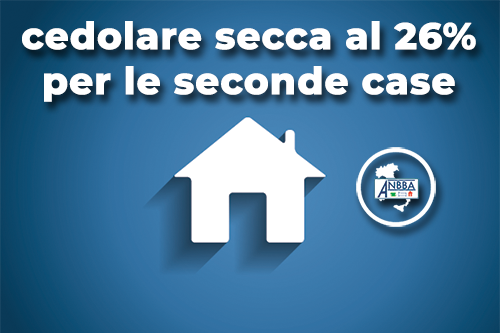
Novità in campo amministrativo e fiscale e le norme in evoluzione
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali e regolamentari, il settore dell’extralberghiero si trova di fronte a importanti cambiamenti. In qualità di associazione di riferimento per i gestori di strutture ricettive non alberghiere, ANBBA ritiene fondamentale offrire ai propri associati e lettori un quadro chiaro e aggiornato su quanto sta accadendo.
Dalla maxi cedolare al 26% alle nuove regole tecniche e amministrative, fino ai contenziosi in corso a livello nazionale ed europeo, la normativa in materia di locazioni brevi sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Riportiamo di seguito una sintesi utile per comprendere l’impatto concreto di queste novità e le possibili prospettive future.
Affitti brevi e maxi cedolare: prime evidenze e contenziosi in corso
Dalle prime analisi disponibili, la nuova aliquota del 26% prevista per la cedolare secca sugli affitti brevi sembra interessare una platea ancora piuttosto limitata. Secondo una stima del Caf Acli, solo circa l’11% dei contribuenti che hanno presentato il modello 730 nel 2025 ha dichiarato di possedere almeno due immobili destinati alla locazione breve – condizione necessaria per l’applicazione della nuova aliquota introdotta quest’anno.
Ricordiamo che il nuovo regime fiscale si applica solo a partire dal secondo immobile in affitto breve: sul primo resta in vigore l’aliquota ordinaria del 21%. L’analisi mette inoltre in luce un dato interessante: tra coloro che affittano più di un alloggio con contratti brevi, il 40% gestisce anche immobili in locazione tradizionale, mentre tra chi ne affitta solo uno, la percentuale scende al 20%.
Un aspetto critico da considerare: il ruolo delle OTA nella ritenuta fiscale
È importante evidenziare un aspetto rilevante che non risulta affrontato dallo studio citato: il ruolo operativo delle piattaforme OTA (Online Travel Agencies), come Airbnb e simili, nella gestione delle ritenute fiscali.
Dal 2023, queste piattaforme sono state qualificate come sostituti d’imposta e, pertanto, trattengono alla fonte l’aliquota del 21% prevista per la cedolare secca sugli affitti brevi. Tuttavia, non sono attualmente in grado di distinguere tra la prima e la seconda locazione dello stesso contribuente. Di conseguenza, applicano sempre la ritenuta del 21%, anche quando dovrebbe essere del 26% per il secondo (o ulteriore) immobile.
In teoria, spetta al locatore regolarizzare la posizione fiscale versando autonomamente la quota aggiuntiva dovuta (la differenza tra il 21% trattenuto e il 26% effettivamente dovuto per gli immobili successivi al primo). Nella pratica, però, è plausibile che molti gestori non effettuino questa integrazione, vuoi per scarsa consapevolezza del nuovo regime, vuoi per difficoltà tecniche o per mancanza di assistenza fiscale.
Secondo ANBBA, proprio questa disfunzione operativa potrebbe spiegare in parte la bassa percentuale di contribuenti risultati “in regola” con il nuovo sistema fiscale, come rilevato nelle prime analisi disponibili.
Norme in evoluzione e contenziosi aperti
Il quadro normativo continua a evolversi, non senza criticità. Dal 2 gennaio 2025 è entrato in vigore l’obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) in tutti gli annunci, con sanzioni previste in caso di omissione. A questo si aggiunge l’obbligo, per i locatori, di dotare gli alloggi di dispositivi di sicurezza come estintori e rilevatori di gas.
Non mancano tuttavia i ricorsi legali. Il TAR del Lazio ha recentemente annullato una circolare del Ministero dell’Interno che imponeva l’identificazione di persona degli ospiti. Altre battaglie legali riguardano regolamenti locali in città come Firenze e Bologna, che introducono vincoli urbanistici o obblighi di cambio di destinazione d’uso per gli affitti brevi. Questi interventi, secondo le associazioni dei proprietari, rischiano di limitare la libertà dei cittadini nel gestire i propri immobili.
IVA e affitti brevi: il pacchetto europeo VIDA
Sul piano europeo, l’introduzione del pacchetto VIDA (VAT in the Digital Age) potrebbe cambiare ulteriormente le regole del gioco. In base alla nuova normativa, a partire dal 1° luglio 2030 (o già dal 2028 per gli Stati che lo adottano in anticipo), le piattaforme online che intermediano affitti brevi dovranno applicare direttamente l’IVA, assumendo il ruolo di “fornitori presunti”. Questo comporterebbe l’obbligo per le piattaforme di riscuotere e versare l’imposta, potenzialmente incidendo sui margini dei locatori.
Ricorsi in corso contro il pacchetto VIDA
Occorre segnalare che sono già stati avviati ricorsi contro la direttiva europea contenuta nel pacchetto VIDA, attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le contestazioni sollevate mirano a evidenziare i potenziali effetti distorsivi sul mercato delle locazioni brevi, in particolare per quanto riguarda l’imposizione dell’IVA attraverso le piattaforme digitali.
Secondo i promotori del ricorso, l’obbligo per i portali di trattenere e versare l’imposta in qualità di “fornitori presunti” potrebbe comportare un aumento dei costi per i piccoli locatori non professionali, riducendo la competitività e spingendo una parte del mercato verso l’irregolarità.
Check-in e sicurezza: tra nuove tecnologie e accoglienza personale
Sulle modalità di accoglienza, dopo l’annullamento della norma sull’identificazione visiva, si riapre il dibattito sull’uso di strumenti digitali per il check-in a distanza. Le associazioni raccomandano comunque prudenza, invitando i locatori a verificare con attenzione l’identità degli ospiti attraverso documenti affidabili, anche per garantire la correttezza delle registrazioni su AlloggiatiWeb.
Impatto sul tessuto urbano: ancora pochi dati certi
Un altro tema molto discusso è l’impatto degli affitti brevi nei centri storici. Diverse amministrazioni locali stanno intervenendo con regolamenti restrittivi, temendo un effetto di desertificazione residenziale. Tuttavia, come segnala anche l’Agenzia delle Entrate in un recente studio, non vi sono ancora prove certe di un nesso diretto tra affitti brevi e riduzione delle abitazioni principali, né effetti significativi sull’offerta di affitti di lungo periodo o sugli acquisti con agevolazioni “prima casa”.
Nota: Questo articolo è una rielaborazione autonoma a cura di ANBBA su base normativa e informativa pubblica, con riferimento a dati diffusi da associazioni di settore e fonti istituzionali. Non costituisce riproduzione di articoli protetti da diritto d’autore.




